Decima puntata della rubrica che vede Daniele Bazzani e Giovanni Onofri parlare delle...
Amicizie e look :-)
Lo scopo era quello di attirare l’attenzione di qualche coetaneo e, magari, di qualche giovane e bella fanciulla. Di gente ne passava tanta, soprattutto bambini che venivano a giocare a pallone, oppure persone anziane che portavano il cagnolino a fare la pipì, ma di ragazzi della mia età se ne vedevano pochi.
Un giorno feci finalmente amicizia con un giovanotto rossiccio, di nome Timoteo, l’unico coetaneo che era stato presumibilmente attratto dai miei capelli lunghi e dal mio aspetto insolito e un po’ stravagante.
 Non andammo mai perfettamente d’accordo e fra noi non si creò il giusto feeling. Infatti, Timoteo mi ascoltava in rispettoso silenzio mentre suonavo la chitarra, forse perché non capiva un tubo di musica e non se la sentiva di esprimere dei commenti, ma non perdeva occasione per sfottere il mio strano modo di vestire e denigrare le mie scarsissime doti calcistiche.
Non andammo mai perfettamente d’accordo e fra noi non si creò il giusto feeling. Infatti, Timoteo mi ascoltava in rispettoso silenzio mentre suonavo la chitarra, forse perché non capiva un tubo di musica e non se la sentiva di esprimere dei commenti, ma non perdeva occasione per sfottere il mio strano modo di vestire e denigrare le mie scarsissime doti calcistiche.
Per la verità, mi ci volle poco tempo per constatare che il mio look era abbastanza arretrato rispetto alle tendenze della moda di quel momento: la zampa dei miei pantaloni era troppo larga, il taglio dei capelli era rocchettaro e le suole ed i tacchi delle mie scarpe erano troppo alti e voluminosi.
Invece, i ragazzi che affollavano il centro e che facevano interminabili vasche lungo il Viale XX settembre, portavano i capelli rigorosamente corti ed ordinati e sfoggiavano accessori ed articoli di abbigliamento abbastanza costosi rispetto al tenore di vita che si poteva permettere la mia famiglia nel 1973: occhiali da sole Ray-Ban (quelli con la lente a goccia, il para-sudore ed il cerchietto), pantaloni a sigaretta Manuel Ritz Rirò, Jeans Fiorucci scoloriti artificialmente e stivaletti a punta alla Texana erano per me oggetti sconosciuti e sicuramente inacessibili.
L'incontro
Un pomeriggio, mentre io e Timoteo stavamo tranquillamente fantasticando seduti sulla solita panchina, si avvicinò un tossicodipendente sui 30-35 anni che volle raccontarci le disgrazie della sua tristissima condizione. Ci disse che era siciliano e che lavorava su di un mercantile che era di passaggio a Trieste.
Aveva avuto molti guai in famiglia e, a causa dell’intervenuta separazione dalla propria consorte, era caduto in depressione, iniziando così a fare uso di sostanze stupefacenti. Aveva un aspetto molto triste e trasandato e le sue braccia erano piene di segni di punture: faceva veramente impressione!
Tuttavia, lo ascoltammo con estremo rispetto e la massima comprensione, senza battere ciglio. Quando, però, ci chiese un aiuto per fissarsi il laccio emostatico ed iniettarsi una dose di eroina, ci parve di morire per lo spavento. Non so nemmeno come feci, ma ebbi la prontezza di spirito di rispondergli: “Ci dispiace, ma non ce la sentiamo di aiutarti a farti del male”!
Sentendo quelle parole il Tizio rimase un po’ sorpreso, annuì, sorrise e se ne andò.
Un nuovo amico
Dopo qualche giorno, Timoteo mi presentò Diego, un ragazzo più grande della nostra età, vestito e pettinato con cura, molto affabile e comunicativo: un tipo decisamente simpatico ed interessante. Aveva quasi diciotto anni, era figlio di separati e viveva con la nonna materna e con il padre, aveva cioè una situazione famigliare abbastanza inconsueta.
Lavorava in una tipografia, giocava benissimo a pallone, aveva una bella Vespa 50, faceva battute molto spiritose ed aveva un discreto successo con le ragazze. Inoltre, ancorché privo di un vero e proprio talento musicale e pur non dimostrando un particolare interesse per lo strumento, riusciva a suonare abbastanza bene la chitarra, sfruttando quelle poche conoscenze che il defunto nonno materno, a suo tempo insegnante di musica e musicista professionista, gli aveva impartito quando era piccolino.
Rimasi subito affascinato dalla sua personalità molto vivace ed allegra e diventammo praticamente inseparabili. Timoteo sparì dalla circolazione ed io, Diego e Patrizio - quest’ultimo mitico possessore di un Ciao della Piaggio di colore giallo, ossia il sogno di tanti quattordicenni della mia generazione - iniziammo le nostre interminabili scorribande per la città: se alle diciassette del sabato ci trovavamo a Servola, dopo un quarto d’ora eravamo scesi alle Rive o in Cavana; se, invece, alle quindici della domenica eravamo saliti a San Giusto o a Opicina, in meno di tre quarti d’ora ci eravamo spostati a Grignano oppure alla Pineta di Barcola.

I miei genitori erano molto preoccupati perché, oltre a rincasare la sera tardi, prendevo brutti voti a scuola e non mi impegnavo seriamente negli studi. Ero molto irrequieto, non riuscivo mai a trovare la giusta concentrazione e litigavo continuamente con i miei compagni di classe, tutti figli di papà arroganti e supponenti che non facevano altro che deridere il mio strano abbigliamento, i miei interessi musicali e la mia cadenza marcatamente piemontese.
Non vedendo l’ora di cambiare aria, visto che quell’anno fui rimandato in tre materie che decisi di non riparare, l’anno scolastico successivo mi iscrissi presso un altro Istituto, dove trovai compagni molto simpatici e professori buoni e comprensivi.
Iniziai, così, a rendere in modo soddisfacente negli studi, tranquillizzando non poco i miei genitori. Grazie a Diego e Patrizio iniziai a frequentare un sacco di gente, soprattutto molte belle ragazze. Nel frattempo, avevo anche imparato ad esprimermi in maniera accettabile in dialetto triestino e ad agghindarmi con maggiore cura, cercando di confondermi il più possibile nella massa per rendermi omogeneo all’ambiente circostante.
Finalmente le cose avevano quindi iniziato a girare
Finalmente le cose avevano quindi iniziato a girare per il verso giusto e la società locale aveva deciso di accogliermi fra le sue braccia anche se, per potermi integrare, avevo dovuto modificare completamente la mia personalità: devo purtroppo ammettere che, a quell’età ero volubile e facilmente influenzabile; ma si sa che la coerenza non è una dote profondamente radicata nei quindicenni ed io, purtroppo, fui uno dei tanti che ha fornito il proprio personale contributo all’incremento della schiera degli “ignavi”.
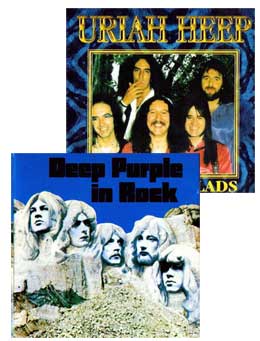 Dulcis in fundo, avevo iniziato a suonare in una piccola Rock Band, i cui componenti, tutti estremamente cordiali e simpatici, mi erano stati appunto presentati da Diego.
Dulcis in fundo, avevo iniziato a suonare in una piccola Rock Band, i cui componenti, tutti estremamente cordiali e simpatici, mi erano stati appunto presentati da Diego.
Di loro ricordo con molto affetto Roberto, il cantante, un giovane molto atletico e prestante, che faceva il pugile dilettante della categoria welters. Era un omone grande e grosso, buono di animo ed estremamente generoso che mi aveva preso sotto la sua ala protettrice, soprannominandomi Bubu, proprio come l’orsetto dei cartoni animati, forse perché ero il ragazzo più piccolo della comitiva.
La nostra Band prediligeva eseguire brani dei Deep Purple e degli Huriah Heep, anche se facevamo di tutto e di più, divertendoci a suonare ad alto volume e a fare un casino del diavolo fino a notte fonda, disturbando il sonno dei poveri Sacerdoti Missionari che ci avevano ospitati nei locali del dismesso lavatoio Parrocchiale.
Certe sere i bravi Padri Sacramentini scendevano in gruppo nel nostro rifugio per fare quattro chiacchiere e, se notavano che eravamo un po’ giù di tono, ci offrivano da bere un bicchiere di buon vino da Messa.
Erano talmente abituati a gestire situazioni estreme in atmosfere del Terzo Mondo, da riuscire a dirimere con facilità le nostre eventuali controversie e a sopportare, senza fiatare, i paurosi muggiti ad alto volume che venivano fuori dai nostri amplificatori. I nostri ospiti non si lamentarono mai del chiasso e, da perfetti educatori quali effettivamente dimostrarono di essere, fecero in modo di conferire la giusta aggregazione al nostro collettivo.
Una volta Roberto venne in mio soccorso, salvandomi da una situazione molto pericolosa ed imbarazzante. C’era un noto e temuto bullo che gironzolava per le strade del nostro rione: un energumeno molto più grande e grosso di me, perennemente a caccia di guai. Per via del colore dei suoi capelli, veniva chiamato con uno spregevole soprannome allegorico (che volutamente ometterò per tutelare la sua privacy).
Quella temibile légera
Quella temibile légera, così vengono definiti certi energumeni in dialetto triestino, fece irruzione, completamente ubriaco, la sera di San Silvestro del 1973 nel nostro bar/ritrovo, nel quale avevamo organizzato un concerto rock, per i nostri amici, che sarebbe durato fino alle sei della mattina successiva. Dopo aver montato il palchetto e sistemato la strumentazione, ci eravamo seduti per giocare una partita a carte per rilassarci un po’.
 Annebbiato dai fumi dell’alcool, il bullo mi scambiò per un altro ragazzo, un tipo alto e scuro che mi somigliava parecchio e con il quale doveva avere qualche conto in sospeso.
Annebbiato dai fumi dell’alcool, il bullo mi scambiò per un altro ragazzo, un tipo alto e scuro che mi somigliava parecchio e con il quale doveva avere qualche conto in sospeso.
Mi aggredì, sorprendendomi da dietro le spalle, mi afferrò per i capelli ed iniziò ad urlarmi delle frasi incomprensibili nelle orecchie. Roberto intervenne prontamente in mia difesa, mi spintonò da un lato e gli disse: “Ciò! Coss’te vol? Te se ga scordato coss’te sucéde se te rompi le bale a Roby?” Quell’altro, facendosi piccolo piccolo, rispose: “… Sucéde che Roby me tira longhi!” (Roberto mi da le botte).
Da perfetto figlio di buona donna, l'energumeno mi chiese prontamente scusa per il disturbo, salutò tutti e si allontanò dal locale di gran carriera. Non lo vidi mai più, ma venni a sapere che aveva già assaggiato più volte le doti pugilistiche di Roberto e che non le aveva gradite molto.
Comunque, il concerto andò benissimo e riscuotemmo molto successo: ripetemmo Smoke on the water e Sunrise svariate volte, visto che i nostri amici andavano in delirio quando ne accennavamo il riff iniziale … sicuramente erano tutti molto bevuti!
Cosa si ballava nelle discoteche triestine di quei tempi?
In alcuni posti andavano alla grande What ever you want degli Status Quo, Can the cash di Suzie Quatro, Skweeze me pleeze me degli Slade, Block buster e The Ballroom Bliz degli Sweet.
In altri locali si preferiva ballare Superstition di Stevie Wonder, Do It Again di Steely Dan, Nutbush city limits di Ike & Tina Turner, Get ready dei Rare Hearth, Outa Space di Billy Preston, oppure China Groove e Long Train running dei Doobie Brothers.
Ma nella maggior parte delle sale troneggiavano I gotcha di Joe Tex, Papa was a rollin’ stone dei Temptations e Sex machine di James Brown.
 Dei brani lenti, messi apposta affinché le coppie potessero sbaciucchiarsi nella penombra, ricordo certe canzoni chilometriche di Barry White, di cui non riesco a rammentarne gli esatti titoli. Oppure, poco prima di tornare agli svelti, tanto per fare quattro risate, veniva messo il disco degli Squallor: “Ti ho conosciuta in un clubs”.
Dei brani lenti, messi apposta affinché le coppie potessero sbaciucchiarsi nella penombra, ricordo certe canzoni chilometriche di Barry White, di cui non riesco a rammentarne gli esatti titoli. Oppure, poco prima di tornare agli svelti, tanto per fare quattro risate, veniva messo il disco degli Squallor: “Ti ho conosciuta in un clubs”.
Qualche D.J., nell’ante-prima della serata, prospettava dei brani di semplice ascolto come Hocus Pocus dei Focus e On the run dei Pink Floyd.
Io crescevo a vista d’occhio in altezza, nutrendomi di pane, salame, salsiccia e catrame. Non mi piaceva molto la musica da discoteca e continuavo, in gran segreto, a coltivare le mie passioni di sempre, arricchendo la mia nastroteca con la musica che rubacchiavo, tramite il radio-registratore regalatomi a Natale, dal noto programma serale della RAI Supersonic - Dischi a Mack II. In particolare, avevo registrato brani dei Deep Purple, dei Pink Floyd, degli E.L.P., della P.F.M. e del B.M.S.
Ma che cos’altro andava in onda in quel periodo?
Poppa Joe - Sweet, Layla - Eric Clapton, Il mio canto libero - Lucio Battisti, Minuetto - Mia Martini, Amor Mio e Grande Grande Grande - Mina, The Show must go on - Leo Sayer Alla long the watchtower - nella versione di Jimi Hendrix, Rock around the clock - nella versione dei Mandrillarium Aequensis, Alone Again - Gilbert ‘O Sullivan, Rocket Man - Elton John, Whithout You - Barry Nilson, A horse with no name - America, Pop Corn - Hot Butter, Sylvia's Mother - Dr. Hook and The Medicine Show, Saturday In the Park - Chicago, I Saw the Light - Todd Rundgren, Vincent /Castles in the Air - Don Mclean, My Love - Paul McCartney and the Wings, Crocodile Rock - Elton John, You're So Vain - Carly Simon, That Lady - Isley Bros. Give Me Love, Give Me Peace On Earth - George Harrison, The Cisco Kid - War, Angie - Rolling Stones, Also Sprach Zarathustra - Eumir Deodato, Money - Pink Floyd, Space Oddity - David Bowie ecc.
 Durante un noiosissimo pomeriggio di una domenica invernale a cavallo tra il 1973 ed il 1974, Diego mi invitò a casa sua per farmi ascoltare un disco dei Grand Funk Railroad, un Complesso che a me piaceva molto e che conoscevo abbastanza bene, dato che avevo letteralmente consumato i vinili di “E Pluribus Funk” e di “Flight of the Phoenix”.
Durante un noiosissimo pomeriggio di una domenica invernale a cavallo tra il 1973 ed il 1974, Diego mi invitò a casa sua per farmi ascoltare un disco dei Grand Funk Railroad, un Complesso che a me piaceva molto e che conoscevo abbastanza bene, dato che avevo letteralmente consumato i vinili di “E Pluribus Funk” e di “Flight of the Phoenix”.
Diego mise la musicassetta nel mangianastri e mi disse: “Caro Bruno, tienite forte alla carega, perché sta’ roba non te la gà mai ascoltada”!
Aveva ragione: il giorno successivo ruppi il salvadanaio e mi recai di corsa in un negozio di dischi, dalle parti di Piazza Goldoni per acquistarlo.
Mi resi immediatamente conto che We’re an American Band era completamente differente dagli Album precedenti: era meno scuro, meno intimo, direi più sfrontato e commerciale! Anche il titolo era spiccatamente auto-celebrativo e caciarone.
Ma come posso trasferire le emozioni ed i sentimenti che animavano il mio turbolento stato d’animo di adolescente quando ho ascoltato per la prima volta quel L.P.? Provo a raccontarlo, cercando di proiettarmi nei pensieri e nei sentimenti di un quindicenne di trentasei anni fa:
We're an American Band
Il brano iniziale della musicassetta si distingue per gli azzeccati cambi di tempo che si sviluppano nelle varie misure, alternando dei momenti abbastanza rilassati a dei passaggi più vivaci e carichi di energia. E’ un pezzo di buona fattura che conquista immediatamente la mia attenzione, grazie soprattutto alla buona impostazione della voce solista e dei cori. Le varie strofe sono divise, le une dalle altre, dagli assoli di Mark Farner, il primo dei quali è abbastanza incisivo e sintetico; il secondo è più cattivo, nervoso e prolungato; il terzo, quello risolutivo, conclude il brano “a sfumare” in maniera molto efficace, essendo caratterizzato da sonorità molto lunghe e meditative.
Questo è un brano abbastanza pacato e carico di atmosfera, costantemente caratterizzato da note decisamente prolungate e stirate che talora possono apparire monotone, ridondanti e, a tratti, anche soffocanti. Sempre pregevole è l’intesa corale delle voci, ben amalgamate ed affiatate. L’assolo centrale del sintetizzatore, piuttosto cupo e leggermente distorto, precede l’inciso eseguito - in sincrono - dalla voce solista e dalla chitarra.
Il finale mi rammenta una tipica atmosfera da film western: il suono cadenzato dei tamburi e dei sonagli, unito al frinire dei grilli in sottofondo, mi porta ad immaginare una sequenza girata in pieno deserto ed a notte avanzata, nella quale si vede una schiera di giovani Pellerossa che danza lentamente intorno al fuoco, mentre gli anziani della tribù, seduti in disparte, li osservano in silenzio scambiandosi serenamente il calumet della pace. Questo quadretto scenografico mi evoca quindi una ambientazione sicuramente omogenea alle tradizioni ed alla etnie che popolano i vari Stati del nord America.

L’Album procede ricalcando delle sonorità molto riflessive e quasi sognanti. I pregevoli arpeggi e gli assoli della chitarra svolgono un intenso lavoro nel corso di tutta la durata di questa lunghissima canzone (durata 6 min. 07). All’epoca ho impiegato diverso tempo prima di trovare le note corrette del riff iniziale però, quando finalmente ci sono riuscito, ho provato una intensa soddisfazione, quasi avessi vinto il Festival dei Castrocaro: nel 1973 non esistevano intavolature, non c’era Internet o Guitar-Pro e certe partiture te le sognavi!.
La tonalità del cantato è molto alta e non riesco a capire se la voce principale sia quella di Don oppure di Mark; probabilmente le strofe vengono cantate in modo alternato da entrambe, riunendosi in coro nei vari ritornelli. L’assolo centrale della chitarra, sempre melodico, struggente e coinvolgente, precede un cambio di tempo durante il quale i vari strumenti si interfacciano con delle sovrapposizioni in “botta e risposta” veramente ben articolate ed interessanti.
Dopo un suono molto pulito di organo, si sente distintamente il rumore di una locomotiva a vapore che parte e che si allontana dalla stazione aumentando gradualmente la propria velocità. Credo che questo insolito effetto sonoro sia stato inserito non tanto alla ricerca di un elemento di originalità da conferire al brano, quanto invece per rappresentare in modo figurativo l’intero contesto, il simbolo e l’essenza originaria della Band, la cui denominazione trae appunto ispirazione dal nome di una ferrovia.
Il puro hard rock mi scuote e mi sorprende proprio con l’ultimo pezzo della facciata A che, se non ricordo male, è anche il lato “B” del 45 giri.
 E’ una canzone piena di ritmo, di groove e di giusta cattiveria che inizia e finisce con lo stesso refrain, confezionato in un modo sicuramente astuto, orecchiabile e maledettamente radiofonico. Quante volte è andato in onda nel biennio 1973/74? Boh! Tantissime.
E’ una canzone piena di ritmo, di groove e di giusta cattiveria che inizia e finisce con lo stesso refrain, confezionato in un modo sicuramente astuto, orecchiabile e maledettamente radiofonico. Quante volte è andato in onda nel biennio 1973/74? Boh! Tantissime.
Dopo un imprevedibile e ben organizzato cambio di tempo, parte il lungo assolo centrale, carico di suono e di intensità, che contribuisce ad arricchire la "corposità" dell’intera canzone conferendole, a tutti gli effetti, un senso compiuto.
Dopo un altro cambio di tempo, si passa ad un assetto ritmico/musicale che richiama alcune sonorità contenute nel brano No Lies del precedente album E Pluribus Funk: un piacevole ritorno al passato.
Questo è un pezzo che mi consente di fare un breve volo trans-oceanico tra il funk ed il rock. Parte l’inconfondibile suono del campanaccio ed il rude flame di batteria, seguiti dall’immancabile “riff” di chitarra che è diventato il tormentone di tanti chitarristi in erba e “scapocchioni” uguali al sottoscritto.
Il ritornello è molto immediato e lapidario e viene praticamente urlato dalla potente e graffiata voce di Don: " Were an american band / Were an american band. / Were coming to your town, well help you party it down. / Were an american band.We're an american band". Parole semplici ed essenziali, ripetute nel finale fino alla noia.
Come si può non riconoscere questa memorabile “hit” fin dalle prime note? E che dire, poi, dell’assolo di chitarra duplicata in contro-canto? Apparentemente semplice, quasi banale, è costituito da una sequenza di note apparentemente di facile esecuzione, ma che così non sono, un po’ perché non riesci a trovare il giusto suono graffiato e miagoloso, un po’ perché non capisci quale sia la corretta diteggiatura e quale sia la giusta dose di equilibrio da seguire nella distribuzione delle varie note.
C’è poco da fare: solo la mano agile e precisa di Mark Farner lo può fare alla perfezione: io e tanti altri, invece, dobbiamo accontentarci e lo dobbiamo eseguire decentemente alla nostra maniera, piuttosto che incaponirci a copiazzarlo, trasformandolo in autentica “fetecchia” e rendendolo addirittura sgradevole ed inascoltabile. Sono sempre dell’idea di essere dignitosamente personali e creativi, piuttosto che ostinarsi a scimmiottare le opere altrui in maniera stridula e penosa!

Il brano successivo è abbastanza veloce e ben cadenzato, organizzato su diversi momenti ritmici. Nella fase iniziale, prima dell’ingresso della voce, il tempo della batteria è in levare ed è gestito a livelli molto sostenuti, energici ed efficaci.
Dopo uno stop, si passa ad un tempo in battere molto più calmo, caratterizzato da scambi di idee molto rabbiosi fra organo e chitarra.
Quindi, parte la strofa cantata con un suono molto riverberato, graffiato, quasi arrabbiato. I vari “I gotcha” urlati da Don, mi ricordano sonorità da discoteca che ho già ascoltato, soprattutto anche per via di quello strano suono di sottofondo leggermente stridulo e metallico che mi è vagamente famigliare. E’ lo stesso strumento che viene usato da Stevie Wonder in “Superstition”, una specie di Clavicembalo elettronico che mi pare si chiami appunto “Hapsicord”.
Segue l’inciso sviluppato su delle linee melodiche leggermente più rilassati, cantati con una voce profonda e potente.
Si ritorna agli scambi di messaggi tra Mark e Craig, il quale pigia i tasti del suo Hammond, ben interfacciato ad un Leslie, facendogli emettere dei ruggiti molto imponenti. Il finale mi riporta nuovamente ad atmosfere selvagge, tipicamente legate ai riti tribali delle tribù pellerossa del nord America. E’ molto carina la versione “umplugged” che appare in una recente edizione ri-masterizzata su CD dell’Album, cantata ed eseguita con l’ausilio della sola chitarra acustica.
Il finale è quasi uguale a quello della traccia originale: contiene, cioè, lo stesso assetto ritmico delle percussioni, con la semplice aggiunta di una armonica a bocca suonata in american style. Nella ristampa di “We’re an American band”, in effetti, compaiono anche altri due altri brani inediti, di buona fattura, intitolati Hooray e The End i quali, per probabili ragioni commerciali, o forse anche per l’eccessiva durata complessiva del prodotto, non furono inseriti nella versione originale.
7.Creepin’
Questa è la vera e propria ballad dell’album, contenente una melodia iniziale molto suggestiva, nella quale si innestano, in sequenza, dopo il piano elettrico, il basso, l’organo hammond ed il canto. E’ una canzone carica di atmosfera e di passione, nella quale non si può non ammirare la chiarezza, e l’estensione della voce di Don Brewer.
 Il Rhodes predomina in quasi tutta la lunghezza della traccia, sviluppando fraseggi con una incedere triste e cupo. Non vorrei apparire blasfemo, ma il ritmo ed il pathos che contraddistinguono questa canzone mi ricordano i riti della Settimana Santa che si svolgono ogni anno a Taranto, nei quali i Confratelli della Parrocchia del Carmine, i cosiddetti “Perdoni”, percorrono l’intera città, rigorosamente incappucciati ed a piedi nudi, procedendo con una camminata lentissima e dondolante che, in vernacolo, viene detta “nazzicata”.
Il Rhodes predomina in quasi tutta la lunghezza della traccia, sviluppando fraseggi con una incedere triste e cupo. Non vorrei apparire blasfemo, ma il ritmo ed il pathos che contraddistinguono questa canzone mi ricordano i riti della Settimana Santa che si svolgono ogni anno a Taranto, nei quali i Confratelli della Parrocchia del Carmine, i cosiddetti “Perdoni”, percorrono l’intera città, rigorosamente incappucciati ed a piedi nudi, procedendo con una camminata lentissima e dondolante che, in vernacolo, viene detta “nazzicata”.
“Hey, everybody won't you lend me your ear / There's something to fear, it's here, and that's clear. / Men gettin' rich off rapin' the land, / I can't understand, why we don't take them in hand”.
A mio modesto parere, è il miglior brano dell’album, nel quale emergono tutte le miglior qualità del Collettivo. C’è addirittura chi l’ha definita: “… una ballata di assoluta bellezza dove le chitarre svolgono un tema melodico, accattivante e la sezione basso/batteria costruisce una base ritmica davvero ben impostata e trascinante, specialmente nella fase finale del pezzo” …
Dopo un brano morbido e suadente, mi viene a svegliare un verso onomatopeico, di natura non precisamente identificabile. “Ahh! Hueiii!” Un verso molto gradito a Diego che ci ha sghignazzato sopra tutte le volte che lo abbiamo riascoltato insieme … E vai! Con un veloce giro di basso, dal suono prepotente e leggermente distorto, nel pieno rispetto dello stile musicale di Mel, seguito dagli accordi in minore settima del piano elettrico - a cui mi piacerebbe aggiungere la nona eccedente - percosso con rabbia dall’ottimo Craig.
In Black Licorice il rock duro si coniuga soavemente con il funk, sfociando in una fulminante cavalcata sonora nella quale predomina l’assolo dell’Hammond che sembra non finire mai: se non conto male, si tratta di ben trentadue battute nelle quali viene eseguita una sequenza pressoché ininterrotta di note, tutte eseguite con estrema precisione, alta velocità e massima intelligenza.
Dopo l’ennesimo “botta e risposta” tra chitarra e tastiera, l’organo riprende nuovamente il comando della situazione ed esegue una sorta di “Bolero” che introduce l’agile e dannatamente sintetico assolo centrale di Mark Farner. Le urla tribali e conclusive del ritornello mi mettono letteralmente i brividi: “Licorice, black licorice …” e …… la cassetta finisce. Mi accorgo di essere aggrappato con le mani alla sedia, esattamente come se mi trovassi seduto su una Ferrari, lato passeggero, lanciata in pista a tutta velocità.
La fine della magia
Dopo qualche mese si interruppe la magia di quei lieti giorni, poiché la mia famiglia dovette nuovamente trasferirsi in un’altra città. Ho ancora negli occhi la tristezza che dimorava negli occhi di Diego e Patrizio quando vennero a salutarmi alla stazione, quando ero salito sul treno che da Trieste mi avrebbe condotto a Taranto: “Ciao Bubu. Ricordite che te gavemo voludo ben”! Con Diego, purtroppo, non ci siamo più rivisti. Patrizio l’ho rivisto una sola volta, una quindicina di anni dopo. Mi farebbe molto piacere poterli rincontrare e, magari, rifare insieme una delle nostre indimenticabili scorribande per la città!

Da allora è passato tanto tempo, eppure qualcuno si è ricordato proprio di me: proprio oggi ho ricevuto una mail da una amica di allora che non avevo mai più visto e sentito. Nonostante i capelli bianchi e la vecchiaia incipiente, è riuscita a riconoscermi dal mio “Avatar” depositato su Internet e mi ha contattato. Mi ha fatto veramente piacere risentirla.
Ad oltre trentacinque anni di distanza posso infine affermare che “We’re an American Band” è un Album di buona fattura che ascolto sempre volentieri. Per me rappresenta anche qualcosa di più dal punto di vista personale: è stato un eccellente amico che mi ha tenuto compagnia nei due anni successivi, quando cioè ho dovuto ricominciare tutto d’accapo, essendo stato proiettato a mille chilometri di distanza dai miei amici, dalla mia piccola Rock Band e dalla deliziosa ragazzina con la quale uscivo.
Ma, per fortuna, quell’esperienza l’avevo già vissuta e sapevo da che parte dovevo ricominciare …
Piccola biografia dei Grand Funk Railroad
A titolo biografico ed allo scopo di dare a questa specie di diario personale la parvenza di di una pseudo-recensione, aggiungo qualche nota biografica, unitamente ad alcuni commenti che ho trovato in giro.
I Grand Funk Railroad era un trio di ragazzi del Michigan, precisamente di Flint, un sobborgo industriale di Detroit. Conseguirono una serie incredibile di successi tra il 1969 e il 1974, vendendo quasi 20 milioni di copie di dischi.
 Il loro produttore originario, Terry Knight, quando faceva ancora il D.J. in una radio di Detroit, ebbe l’intuito e la fortuna di scritturarli facendo loro sottoscrivere un contratto discografico le cui clausole si rivelarono, in seguito, molto vessatorie. Organizzò per loro una enorme campagna pubblicitaria, tappezzando di manifesti l’intero centro di New York e li accompagnò al grande successo, prima nazionale e poi internazionale.
Il loro produttore originario, Terry Knight, quando faceva ancora il D.J. in una radio di Detroit, ebbe l’intuito e la fortuna di scritturarli facendo loro sottoscrivere un contratto discografico le cui clausole si rivelarono, in seguito, molto vessatorie. Organizzò per loro una enorme campagna pubblicitaria, tappezzando di manifesti l’intero centro di New York e li accompagnò al grande successo, prima nazionale e poi internazionale.
Terry Knight è morto il 1º novembre 2004, all'età di soli 61 anni, stroncato dall’uso sfrenato di sostanze stupefacenti, lasciando dietro di sé il rimorso di aver perso nel 1971 la collaborazione con questo memorabile Gruppo Musicale. Mark Farner , dopo la tragedia della sua scomparsa, ebbe a dire: "Dopo tanti anni avrei voluto dirgli che lo avevo perdonato, che non gli serbavo più rancore per averci derubato tutti i nostri guadagni... purtroppo adesso è tardi" …
La Band era formata in origine da tre elementi - non proprio del tutto eccezionali se considerati singolarmente - che però costituivano un valido collettivo, in quanto principalmente dotati di due buone voci soliste: quella di Mark Farner (cantante, chitarrista e autore della maggior parte delle loro canzoni) e quella di Don Brewer (batterista e leader del gruppo).
Con “We're an American Band” (album nel quale entrò ufficialmente a far parte dell'organico il quarto elemento del Gruppo, il tastierista Craig Frost) i G.F.R. raggiunsero il culmine della propria creatività e conseguirono il momento di maggiore notorietà, entrando nelle hits dei Top 100 del 1973.
Purtroppo, proprio in concomitanza con il grande successo conseguito, ebbe inizio il loro declino artistico e musicale, caratterizzato da un progressivo e tangibile affievolimento della loro ispirazione musicale e della loro vena compositiva.
Quello che si può considerare ultimo album della loro produzione originaria, Good singing good playing, fu prodotto nel 1976 dal grande Frank Zappa, rimasto appunto memorabile per il lungo assolo contenuto in Out to get you che fu appunto eseguito dall’indimenticabile grande chitarrista prematuramente scomparso nel 1993.
I G.F.R. vengono ricordati dalla maggior parte del pubblico per i brani scritti per loro da terze persone come, ad esempio, The locomotion e Loneliness, piuttosto che per il loro effettivo talento creativo e musicale. Occorre inoltre sottolineare che la Band, dopo il successo iniziale, fece molta fatica a trovare Produttori discografici disponibili a pubblicare i propri dischi, eccezion fatta appunto per Frank Zappa e Todd Rundgreen.
 In buona sostanza, non facevano Jazz, Fusion, Progressive oppure Rock Sinfonico: suonavano un sano ed essenziale hard rock, niente più e niente meno di tante altre Band loro contemporanee.
In buona sostanza, non facevano Jazz, Fusion, Progressive oppure Rock Sinfonico: suonavano un sano ed essenziale hard rock, niente più e niente meno di tante altre Band loro contemporanee.
Personalmente non ho mai però condiviso il forte pregiudizio ed i commenti feroci che la critica mondiale ha espresso nel confronti di questo valido Collettivo, causandogli irreparabili danni di immagine che lo hanno costretto a sciogliersi e ad abbandonare le scene musicali nel lontano 1976.
Noti alla massa per le loro spettacolari performance dal vivo, i G.F.R. furono infatti insigniti, dalla critica musicale, del poco edificante titolo di “loudest band in the world”, ossia la band più rumorosa del mondo.
Io sono cresciuto ascoltando la loro musica e We’re an American Band ha rappresentato la mia personale colonna sonora del triennio 1973/1976.
Mi ha fatto realmente piacere aver scoperto che Homer, il panzuto e un po’ grullo capostipite dei Simpson, li abbia venerati durante alcuni episodi dei noti Cartoons americani, esprimendo elogi estremamente gratificanti. Ma ancor di più mi stupisce che molti giovani dei nostri giorni, compreso mio figlio ed alcuni suoi amici, ascoltino la loro musica e li ammirino molto, forse perché nel panorama musicale attuale non hanno molti altri punti di riferimento.
Citazioni
Qualcuno ha scritto che “ … I G.F.R. rappresentano la risposta statunitense allo strapotere inglese in quegli anni in campo heavy rock .... Questo trio straordinario composto da funambolici musicisti quali Mark Farner (chitarra/voce), Mel Schecher (basso), Don Brewer (batteria), se la giocavano alla pari negli anni settanta con gruppi ben più famosi di loro, almeno in Europa. La miscela di Blues, Funky, Rock, che li contraddistingue, ha permesso loro di creare album unici e di rimanere impressi nella memoria di parecchie persone per le loro prestazioni live mozzafiato come testimonia il "Live Album" (1970) tra i migliori album live di tutti i tempi. Snobbati dalla critica perché troppo semplici, privi di qualsiasi pretesa, rumorosi e brutali, riuscirono a far breccia tra le persone proprio grazie a queste caratteristiche, polverizzando perfino il record dei Beatles quando si trattò di riempire lo Shea Stadium”.
E’ anche stato scritto che: “… Con "We re an american band" i Grand Funk Railroad nel 1973 hanno incrementato la propria autorevolezza e successo nel panorama hard rock del periodo. Proprio quest'ultimo lavoro, qui oggetto di recensione, merita più di una nota di apprezzamento sia dal punto di vista strettamente compositivo, sia per quanto concerne la qualità tecnico strumentale. Il disco si presenta essenziale, diretto, ancora a distanza di tempo, addirittura fresco: merito di una collaborazione artistica tra i membri del gruppo evidentemente ad alti livelli. Quest'essenzialità a livello musicale si riflette poi nella copertina, interamente su sfondo giallo con su scritto, quasi sentenziando, "We're an american band" .
Discografia:
%20%5B1973%5D.jpg) 1969 - On Time
1969 - On TimeLive albums
Compilation albums
 1972 - Mark, Don and Mel: 1969-71
1972 - Mark, Don and Mel: 1969-71
Ciao a tutti da Brunoritchie.
I Più Letti
Line6 STAGEScape M20d
Line6 è nota per le sue soluzioni innovative ed "anticonvenzionali" in un...
Line6 M5
Line6 M5 è la sorella minore della famiglia di pedaliere multieffetto della...
iKEY-Audio G3
Eccoci qui a recensire uno dei tanti registratori portatili che sono in...
ARIA
Proseguo nel mio tentativo di descrivere curiosità , stranezze e rarità in...
Analisi Armonica di Autumn Leaves
Analisi Armonica di Autumn Leaves